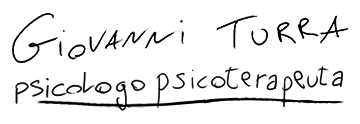La pazza gioia
Cari,
è molto che penso di scrivere qualcosa sul bellissimo film di Virzì e Archibugi, la Pazza Gioia...
Credo che noi che ci occupiamo di relazione d'aiuto, e anche di presente, delle sue profonde inquietudini, potremmo trarre molte, molte riflessioni da questo bellissimo film.  Non è la prima volta che un film sul disagio psichico, disagio sociale e familiare, visto dalla Archibugi, mi colpisce profondamente.
Non è la prima volta che un film sul disagio psichico, disagio sociale e familiare, visto dalla Archibugi, mi colpisce profondamente.
Accadde già con "il grande cocomero", film straordinario, di ormai vent'anni fa, e anche più, in cui ancora però si sentiva vicina la lezione basagliana. C'erano giovani neuropsichiatri (lì in quel film ci si ispirava al giovane Lombardo Radice, allievo del grande Bollea...), c'erano ancora, pur nella disillusione nel vicino riflusso, che spingeva gli operatori a cercare rifugio nelle cliniche private, a girare la faccia dall'altra parte...però si sentiva ancora in quel film tutto il miracolo di un sapere, un sapere "psi", che era capace di fare barriera, di fare argine, ad una società che voleva ridurre tutto a denaro, da una parte, e a biologia, medicalizzazione, dall'altra.
Il film di oggi, invece, dopo oltre 23 anni, è un film leggero, una commedia.
Non che "il grande cocomero" fosse una tragedia, ma insomma c'era ancora lo schema del buono che sa, che cerca di farsi strada con un sapere... C'era ancora molto forte un'idea di spiritualità, di ineffabile.
In questo film invece, davvero pieno di misericordia per tutti, non ci sono più i buoni e i cattivi, non c'è più chi sa e chi non sa.
Le due protagoniste sono squinternate, ma questo non le priva della loro umanità e credibilità. Tuttavia, il godimento mortifero che traggono dal loro sintomo, impedisce loro di essere libere. Vanno via, fuggono, ma come pietre, finiscono sempre dove il loro godimento le porta: Donatella, dal suo ex, da cui cerca disperatamente e assurdamente, masochisticamente, un riconoscimento, una parola. Parola che non arriverà mai. Dietro a quella ricerca masochista e forsennata, ci sono i suoi due genitori, ognuno dei due incapaci di darle questa parola, questo riconoscimento. Ma lei non lo vede, non riesce a mentalizzare questo. Con la madre, agisce una violenza selvatica, senza parole possibili; il "no" che la madre ha detto al figlio di Donatella, è il "no" incarnto nella sua stessa carne, è il rifiuto che la rende oggetto di godimento, goduta dalla madre. Quanto al padre, bacia la mano ignara, non vuole vedere. Lo idealizza e lo tiene lì, gli chiede disperatamente scusa, scusa per essere venuta al mondo, e questa è la sua "cifra" soggettiva.
L'altra, Beatrice, certo ha qualche risorsa in più, perché attorno al suo vuoto psicotico c'è stata tanta bellezza, tanta ricchezza (tovaglie di fiandra, bei bicchieri di cristallo, barche a vela ...), e io so, e credo anche voi sappiate, quanto la bellezza e la ricchezza possano aiutare, possano fare supplenza. Questo le da' inoltre anche un poco di energia posticcia, un po' di perversione che le consente di parassitare l'Altro.
E' simpatica, coinvolgente, nel suo transfert e nella sua capacità di suscitare affetti, legami simbiotici. Lei si "attacca" come una zecca, e poi però certo tende ad usarti.
Con Donatella, Beatrice però struttura un transfert in cui uno spazio si crea. Certo è casuale, forse, ma alla fine Beatrice riesce a portare Donatella sulla scena della sua vita, delle sue scansioni.
Il film è costruito attorno a queste due donne e alla loro follia, ma quello che io credo interessante, per noi, è lo sguardo, disincantato ma anche generoso, misericordioso direi, sulle strutture di cura.
Basaglia è ormai lontanissimo. Il filma fa vedere benissimo le logiche, le "procedure" fredde e de-responsabilizzanti, dei vari Servizi e del loro interfacciarsi. Fa vedere una Comunità dove tuttavia un certo "vuoto" è preservato. E' preservato un vuoto, uno sfilacciamento, da cui le due donne possono scappare, ma prima di questo, ancora, possono incontrarsi, e questo incontro, questo transfert, non è "trattato" in modo disciplinare, pedagogico.
Le due donne vengono messe in camera insieme (nonostante Beatrice avesse preso la cartella clinica dell'altra, forzando l'armadietto chiuso a chiave, e nonostante avesse cercato di avvicinarla fingendosi medico ...) e le modalità con cui si relazionano, a partire dai loro sintomi, vengono osservate con affetto partecipato. Bellissima è la scena dell'équipe, unica vera utopia del film, in cui tutti sembrano davvero parlare dei pazienti, scambiandosi e prendendosi a prestito metafore... lì la metafora del figlio ("se non sono gigli son pur sempre figli" .... viene in mente De Andrè, che poi in effetti è citato nella bella canzone della comunione, dove in questione è il mistero di una maternità che trasforma per sempre) è alla fine, io credo, il messaggio del regista: tutti siamo figli, poveri diavoli in qualche modo.
C'è negli operatori una mansuetudine straordinaria. Loro sanno di dover galleggiare su un mondo delle cure, che pure viene mostrato nelle sue assurdità. C'è il rituale dei farmaci distribuiti la sera, e le pazienti che se li scambiano e ne fanno un mercato, e persino un rituale profano, con farmaci al posto della comunione insieme al vino ... C'è naturalmente il moralismo del discorso "pedagogico" e disciplinare dell'assistente sociale, con dietro le sue soluzioni "interventiste" che poi tanto non hanno futuro, non hanno gambe... Chi si prende davvero le famose, famigerate, responsabilità? Nessuno le vuole davvero....per questo è meglio, con mansuetudine, lasciare libere le persone di incontrare il loro vuoto.
C'è infatti lo sguardo impietoso del regista sui corpi degli operatori. Quelli più "in basso", infermieri, ASA, suore e operatori dell'OPG, sono sformati, grassi, oppressi da troppe contraddizioni e impotenze, oppressi dal corpo a corpo con il paziente, sul quale devono poi - loro - agire la brutalità di un processo di cura che è alla fine esclusione, segregazione, identificazione con l'aggressore.
Quelli più in alto, invece, giovani e delicati, ancora capaci di sguardi umani, sono spesso impotenti, piegati comunque a logiche che non possono cambiare.
E intorno, tutta una società civile che si rivela nella sua pochezza, eppure che ha una sua etica, incredibilmente. L'autista che non permette a Beatrice di consegnare il denaro al bruto di cui lei è innamorata, il porcellino che voleva portare le due donne in albergo, ma che poi le lascia comunque andare, quando recupera la sua auto, rubata per una bravata. E alla fine, questi gesti, piccoli gesti, di un'etica del lasciar fare, del fare un piccolo passo indietro, del non accanirsi, è ciò che si incarna nel gesto del padre affidatario, che ferma la sua compagna, e permette a Donatella il breve dialogo finale con il figlio.
E' lì, quel breve dialogo, quel dire al bambino (in funzione simbolica, paterna) "vado dove posso stare meglio, e poi magari ci si rincontra", che c'è tutto l'effetto, la possibilità, di una cura per la psicosi: le due donne, tornano spontaneamente nella Comunità, nel luogo caotico ma "bucato", nel luogo da cui hanno potuto scappare, e dove poi possono fare ritorno, spontaneamente, attivamente.
Fra "Il grande cocomero" e questo film qui, in mezzo c'è "Tutta la vita davanti", che pure ha avuto la consulenza di Francesca Archibugi. In quel film, il disagio psichico era più disagio nevrotico, disagio della periferia urbana, ma forte era però il peso, anche lì, di un "discorso sociale" a cui i giovani, ma non solo loro, erano assoggettati fino alla disperazione, all'alienazione, alla follia.
Lì il gesto folle era quello finale, della grandissima Ferilli, ma dietro a questo gesto spropositato, c'era tutta l'escalation e il non senso di un mondo che disprezza ciò che ha valore: il sapere, l'impegno, il rapporto con i minori e con gli anziani e i malati, gli affetti... e da' valore a ciò che in realtà è truffa, vuoto. Dietro all'apparente lavoro di squadra, c'è l'umiliazione, lo sfruttamento, la mistificazione e la distruzione da dentro alle parole stesse, di un mondo, che in pochissimi anni è distrutto; anche il discorso sindacale, i diritti, i partiti, ecc., è già roba vecchia e inservibile, e le giovani telefoniste lo sanno.
Il cinema, insomma, anche il nostro cinema, ci fa vedere molto bene e da vicino dove siamo, come va il mondo, come va anche il mondo della cura in cui noi siamo immersi e attivi. E' un mondo in cui il sociale, la politica, l'economia, è dentro, siamo dentro fino al collo.
Anna Barracco